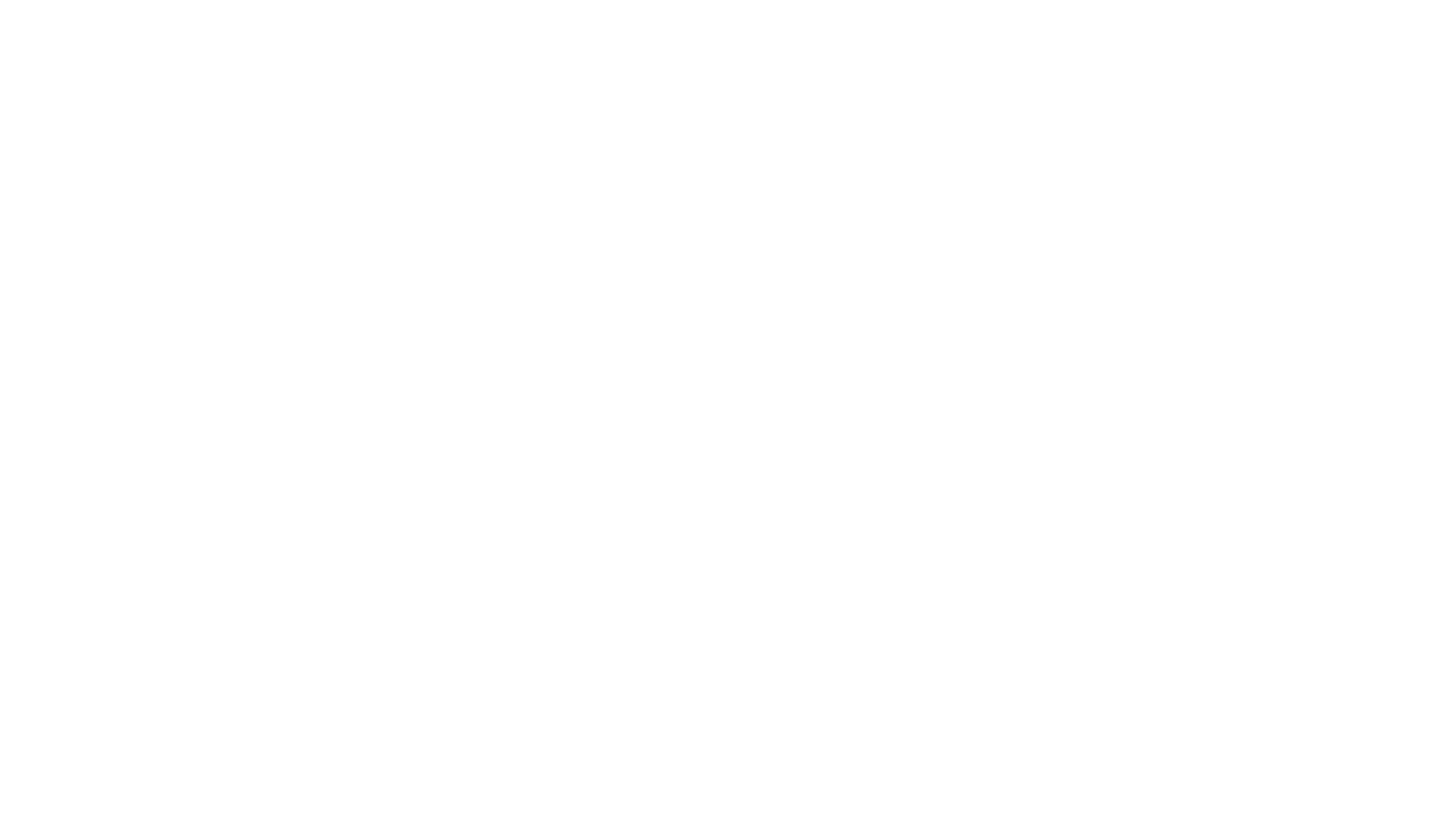Di Claudio Baccarani
Caro Santo Padre,
scrivo questa lunga lettera per sottoporLe alcune riflessioni emerse da una lettura della Sua Enciclica Laudato si’. Il desiderio di scriverLe è scattato immediatamente dai primi passi dell’Enciclica ed è divenuto pressante nella prosecuzione della lettura perché incontravo temi e argomenti che fanno parte del mio lavoro quotidiano.
Io, invero, insegno all’Università di Verona da tanti anni, ne ho ora 68. Insegno Economia e Gestione delle Imprese o, se vogliamo, Management, ossia come governare e gestire le imprese e le organizzazioni in genere.
Perché ho fatto questa scelta? Ricordo che da giovani avevamo tante idee; in realtà, appartengo a quella generazione che ha vissuto il ’68 con tutti i suoi sogni per un mondo più equo e felice. Pensavo, come tutti i giovani, di poter cambiare il mondo, poi ho capito che non è cosa da affidare solo ai sogni.
Ho però anche capito che senza sogni nulla può cambiare. Così ho deciso di provare a fare questo mestiere con un grande sogno nel cassetto, e devo dire che questo percorso è stato possibile solo perché sulla mia strada ho trovato tanti che mi hanno ascoltato, sostenuto in vari modi e dedicato il loro tempo perché io potessi raggiungere questo obiettivo.
Ero, e sono, convinto che, se si vuole cambiare il mondo per diffondere un benessere – non solo materiale – per tutte le persone , occorre partire dal come viviamo l’economia. È questa infatti che, con una “mano più o meno invisibile”, guida i processi evolutivi ben più della politica e della tecnica.
Così, da incorreggibile sognatore, ho intrapreso questa strada. Con i miei studi e le mie ricerche non ho certo rivoluzionato nulla, ma qualche idea sul come l’impresa possa contribuire a cambiare il mondo ha attraversato il mio cammino ed ho cercato di raccoglierla e diffonderla nelle lezioni, nelle discussioni con colleghi e imprenditori come pure negli scritti.
Ed è al riguardo di questa idea che Le scrivo, perché si collega a un tema che Lei ha disseminato in qua e in là nella Sua Enciclica e che variamente riprende nei suoi discorsi: il profitto e il suo ruolo nel mondo moderno.
Nella Sua Enciclica il profitto emerge in più pagine sotto un aspetto critico per quello che ha prodotto in termini di consumismo compulsivo, pensiero breve, scarti, rifiuti, degrado ambientale, cultura egoistica fondata solo sul sé, squilibri nelle comunità e tra i diversi Paesi, graduale distruzione di risorse che non sono più rigenerabili.
Tutto questo in nome del mercato e delle sua ipotetica capacità di generare e diffondere benessere attraverso l’impegno competitivo dei soggetti che lo animano. In realtà, il fallimento del mercato da questo punto di vista è sotto gli occhi di tutti per l’individualismo che ha generato, l’avidità che ha diffuso, gli scompensi tra le diverse classi sociali che ha contribuito a creare, le disperate migrazioni di massa alle quali assistiamo con angoscia.
Indubbiamente, oggi il profitto è l’idea guida che muove i comportamenti della maggior parte delle imprese. Ed in particolare di quelle di grandi dimensioni, nelle quali chi dirige è come si trovasse su una dorata navicella spaziale da dove comanda senza minimamente sentire il pulsare della vita all’interno dell’impresa, né tantomeno all’esterno della stessa nei territori e nelle comunità dove vivono le persone.
Per non dire della finanza che ha perso in gran parte il proprio ruolo di sostegno all’economia reale per cercare di produrre ricchezza puramente virtuale fondata sulla speculazione, sull’incompetenza e l’insensatezza di tanti attirati dall’illusione di facili opportunità di arricchimento.
Ed è così che nei dibattiti politici, ma ormai purtroppo anche nei discorsi comuni, il termine al quale tutti ci si inchina quasi in venerazione è la crescita, come se questo fosse sinonimo di sviluppo della qualità della vita e di progresso nella redistribuzione del benessere prodotto. Quando ben si sa invece che la crescita è solo quantità, mentre lo sviluppo è qualità e il progresso è diffusione di benessere.
La crescita è divenuta un mantra, si sostiene che senza crescita non vi possono essere sviluppo e progresso. Se solo invece pensassimo al superfluo nei consumi in un’economia non più dei bisogni e dei desideri ma dei capricci, allo spreco delle economie progredite e alle possibilità di crescita delle economie povere, ben risulterebbe chiaro che anche in una situazione di contenimento dei nostri consumi si potrebbero avere condizioni di sviluppo e progresso diffuso.
Per cambiare questa logica è necessario un profondo mutamento culturale che viene però facilmente soffocato dalla comunicazione, pubblicitaria e non, che fa leva sul luccicare dei consumi, sul benessere dell’individuo e sulla paura di perderlo a vantaggio di altri. Tale mutamento, peraltro, non viene nemmeno sostenuto dal cambiamento di regole nella governance delle imprese e dei mercati.
Eppure, e qui sta l’idea, si potrebbero far coesistere crescita, sviluppo e progresso se solo si ricollocasse il profitto nel suo ruolo essenziale di strumento di sostegno e misura di un processo e non di fine in se stesso. È semplice: non si produce per fare profitto, si produce per creare benessere; si produce pensando agli altri; in questo modo il profitto non lo si deve cercare: sarà, infatti, il profitto che raggiungerà l’impresa che agisce secondo questo principio.
In che modo? Semplicemente, come detto, considerando il profitto per quello che realmente dovrebbe essere, uno strumento e non un fine. Uno strumento che misura e sostiene la capacità competitiva di un’organizzazione e niente più. Un risultato necessario per procedere nel progredire delle imprese e delle comunità, ma non un idolo cui inchinarsi per agire in funzione della sua massimizzazione fine a se stessa.
In realtà, il convincimento di fondo che ho raggiunto in questi anni è che il profitto “più lo cerchi meno lo trovi”.
Il profitto può essere, è vero, il risultato di forze dominanti e speculative che agiscono per il proprio tornaconto nel breve, ma è anche il risultato di tante “buone imprese” che agiscono per produrre benessere pensando agli altri prima che a loro stesse e che in questo modo accostano la produzione di benessere a quella del profitto. Pensando agli altri, cioè a chi? Ai clienti, alla comunità, a chi vi lavora, ai fornitori, insomma a tutta la rete di soggetti e organizzazioni con le quali interagiscono.
Si tratta di un tipo di impresa che amo definire “impresa armonica”, quella che mette veramente le persone al centro dell’attenzione senza bisogno di dirlo nella pubblicità, quella che si muove con una visione che trascende il sé, lavora per aiutare gli altri, cerca di costruire un mondo migliore, agisce cioè per perseguire il bene comune. Sono imprese guidate da persone ben consapevoli della necessità di agire secondo principi di sostenibilità perché consce del fatto che “non abbiamo ricevuto questo mondo in eredità dai nostri padri, ma in prestito dai nostri figli”. E sanno anche che la ricerca della sostenibilità implica la disseminazione della crescita in tutte le parti del mondo attraverso la diffusione di conoscenza e tecnologia per uno sviluppo possibile e coerente con ogni realtà nel rispetto della diversità. Come pure sono ben consapevoli della necessità di raggiungere risultati economici positivi e soddisfacenti.
Queste imprese non devono inseguire il profitto per la semplice ragione che è il profitto che le insegue come premio per il benessere che contribuiscono a generare e diffondere.
Il profitto in queste imprese è di casa, ma come un amico, non come un despota al quale si deve rispondere.
Devo confessare che all’inizio, quando sostenevo questa impostazione, la gran parte dei colleghi con i quali ne parlavo a stento nascondeva un sorriso canzonatorio nel riconoscermi la capacità che dimostravo di creare suggestioni, immagini, forme fantasiose, tipiche però solo di un mondo immaginario generato dal mio vero o presunto vagare tra le nuvole.
Certo non sono l’unico studioso, sia tra gli italiani che tra gli stranieri, ad aver affrontato e sostenuto simili tesi con pochi riconoscimenti da parte delle impostazioni economiche più diffuse.
Tuttavia, ora la ricerca ha individuato imprese che agiscono secondo principi del tutto in linea con quanto indicato.
Ora sappiamo che governare e gestire un’azienda secondo modalità dai tratti simili a quelli delineati è possibile, si può fare.
Sappiamo che esistono imprese armoniche, buone imprese, imprese umanistiche, benefit corporations, le si chiami come si vuole, imprese che vivono la relazione con il mercato fondandola sulla centralità delle persone e delle loro esigenze piuttosto che su quella del profitto. Imprese che così agendo producono, peraltro, risultati lusinghieri misurati proprio dal profitto realizzato.
Insomma, ora non si può più sostenere che questo modello di impresa sia frutto di fantasia, di sogni, di utopie.
Verificato che un diverso modo di vivere l’economia e l’azienda in forme comunitarie e individuali nel contempo è possibile, si tratta di vedere come diffonderlo.
Cosa può accelerare il cambiamento necessario per correggere un sistema socio-economico non più sostenibile nel lungo periodo per i danni e gli squilibri che provoca?
Una possibile strada sta nel dare voce a queste imprese, nel metterle in luce, nel mostrare che è possibile accostare benessere e profitto.
È quello che cerco di fare e che altri nel nostro Paese e in altre parti del mondo stanno facendo, ma le nostre voci sono come gocce in uno smisurato oceano di comunicazioni dirette a stimolare i consumi e di tensioni che si susseguono inarrestabili a richiamare l’attenzione delle persone sull’individuo più che sulla comunità.
Il tempo darebbe certo ragione a queste voci, ma questo tempo potrebbe essere troppo lungo rispetto alla rapidità della distruzione generata dall’attuale approccio alla gestione dell’impresa e dell’economia.
Per non correre questo rischio, fondamentale sarebbe che questa “verità nascosta” fosse portata alla luce da una voce ascoltata e autorevole, la Sua, per diffondere speranza e riconoscimento in chi orienta la produzione nella direzione del bene comune e un seme di salutare dubbio in chi seguita a gestire l’impresa secondo i vecchi schemi devoti al profitto.
Questo potrebbe davvero avviare e sostenere una rivoluzione possibile perché, incoraggiando un cambiamento nella mentalità imprenditoriale, lo farebbe partire dal basso, da chi vive la quotidianità dell’azione giorno per giorno sulla propria pelle. Da lì, gradatamente, per inevitabile contaminazione, potrebbe raggiungere e guidare l’agire della politica e della tecnica, perché l’impresa alla pari della famiglia rappresenta una delle cellule fondanti il sistema sociale.
Non so se potrà leggere questa lettera, non so se è solo confusa, non so se sto coltivando un sogno troppo grande, non so nemmeno se sono riuscito a descriverlo; so però che se Lei ritenesse di muovere qualche passo in questa direzione e ritenesse che i pensieri e le evidenze raccolte con la nostra ricerca potessero essere di qualche utilità, certo mi potrebbe ritenere a totale ed entusiasta disposizione.
Claudio Baccarani
Dipartimento di Economia Aziendale, Università degli Studi di Verona
claudio.baccarani@univr.it
31 dicembre 2016