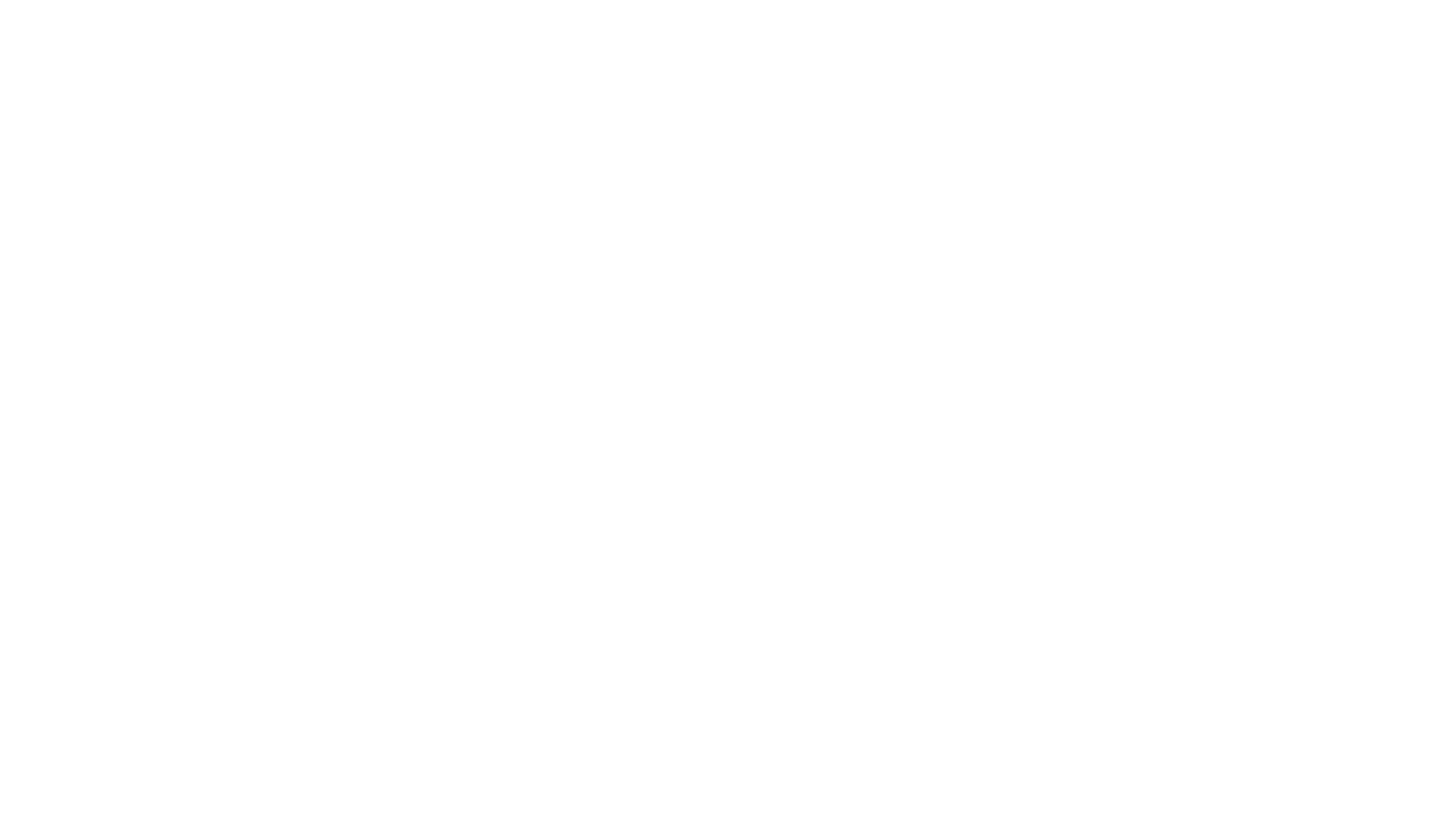Il 12 giugno gli italiani saranno chiamati alle urne per i Referendum abrogativi sulla giustizia. Lo stesso giorno si svolgeranno le elezioni amministrative in 970 Comuni, di cui 21 capoluoghi di provincia.
Una corretta analisi dei quesiti referendari è fondamentale per esercitare consapevolmente il proprio diritto di voto. In questo caso la complessità della materia oggetto dei referendum ci obbliga ad andare oltre i titoli dei giornali o gli strilli della politica. È necessario un approfondimento serio ad ampio spettro che ci aiuti a comprendere gli scenari passati e presenti, permettendoci un salto di qualità nelle scelte future.
Da qui l’incontro con l’avvocato Enrico Grosso, professore di Diritto Costituzionale al dipartimento di Giurisprudenza presso il Campus Luigi Einaudi di Torino, per parlarne eticamente, offrendo al lettore un’ottica autorevole, e tecnicamente competente, che ci aiuti a fare chiarezza sul referendum del 12 giugno prossimo.
Prof. Grosso, ora che il dibattito televisivo non è ancora aperto, anche a causa dei tragici eventi in Ucraina, è il momento adatto per entrare nel merito dei significati politici e tecnici che si sommano in questo referendum sulla giustizia. Alcuni quesiti riguardano direttamente temi come la legge elettorale del CSM, il funzionamento dei consigli giudiziari, ma soprattutto l’assetto ordinamentale della magistratura. Viene da dire che non sono propriamente materia alla portata di tutti i cittadini.
Questo referendum risponde forse ad una rottura che ha raggiunto il suo apice tra politica, avvocatura e CSM, arrivando a chiedere ai cittadini di scegliere, cancellando norme di cui non sempre è chiaro il significato. Ma quale peso politico e quali piani tocca questa iniziativa referendaria?
L’iniziativa referendaria in atto ha sicuramente un significato politico che trascende largamente il risultato tecnico dell’eventuale abrogazione delle norme sottoposte a quesito. Anzi, possiamo dire che, sotto il profilo strettamente tecnico, nessuno dei referendum proposti, proprio per la natura inevitabilmente rozza dello strumento, meramente abrogativo di norme esistenti, può ragionevolmente conseguire l’obiettivo di realizzare una qualsiasi plausibile riforma di struttura dell’ordinamento giudiziario. Da questo punto di vista, solo un intervento del legislatore, compiuto e strutturato, può intervenire sui punti più critici dell’attuale assetto della giurisdizione e apportavi le modifiche che da più parti sono richieste. Il problema è che, sul contenuto e sugli indirizzi da dare a tale intervento, non vi è consenso né tra le forze politiche né nel confronto tra la politica e gli attori del sistema giustizia (magistratura e avvocatura).
Ne è testimonianza il recente fragilissimo compromesso raggiunto alla Camera sul disegno di riforma proposto dal governo, su cui non si sa ancora se si coagulerà un consenso sufficiente in Senato. E comunque, si tratta di un compromesso del quale tutti si dichiarano sostanzialmente scontenti, per opposte ragioni (punitivo secondo l’ANM, insufficiente secondo le Camere penali, sostanzialmente inutile secondo alcuni settori dello schieramento politico). In tutto questo, i referendum agiscono, nell’intento dei loro promotori, come il classico “convitato di pietra”. Tutti sanno che, tecnicamente, non risolvono alcuno dei problemi in discussione, ma c’è chi li agita per il significato politico generale che, al di là di quei risvolti tecnici, essi assumerebbero in caso di vittoria dei Sì. L’impatto sarebbe tutt’altro che trascurabile, ma appunto su un piano completamente diverso, che definirei un piano più “spirituale” che “materiale”, e proprio per questo molto più insidioso. Inoltre, ciò che è più grave, si tratterebbe di un effetto “inconsapevole”. I singoli quesiti restano alla maggior parte dei cittadini largamente incomprensibili. Si potrebbe addirittura dire, da questo punto di vista, che sono quanto di più lontano si possa immaginare rispetto alla “materia referendaria”, intesa nel senso non tecnico di ciò che è “ammissibile” ai sensi dell’art. 75 della Costituzione, ma di ciò che sarebbe ragionevole, secondo lo spirito dell’istituto referendario, sottoporre all’attenzione diretta dei cittadini. È un uso surrettizio del referendum. Un uso disonesto. Molti aspetti dell’ordinamento giudiziario possono e devono essere modificati. Ma non possono che esserlo da parte del Parlamento nell’ambito di interventi complessivi e di sistema, che siano adottati all’esito di un’analisi in grado di andare alla radice degli attuali problemi organizzativi dell’ordine giudiziario e delle sue disfunzioni, ponendo rimedi seri e adeguati alla natura di quei problemi. E, soprattutto, dando soluzioni degne a questioni complesse. Il referendum rappresenta invece di per sé una risposta semplificata, rozza ed incompleta, perché inevitabilmente manichea. Una risposta che si rivela, alla fin fine, insoddisfacente. Questo lo sanno tutti, anche i promotori. Alcuni però usano cinicamente lo strumento referendario, pronti a strumentalizzarne gli effetti e trarne un dividendo politico.
La Corte Costituzionale ha bocciato il quesito sulla responsabilità civile dei magistrati. Questo di fatto cambia il peso di tutto l’impianto politico che mirava a depotenziare l’indipendenza della magistratura?
Sicuramente il quesito sulla responsabilità civile diretta era quello diretto a colpire più duramente, anche sul piano simbolico, uno dei pilastri su cui si regge il principio di autonomia e indipendenza della magistratura. Tutta la campagna referendaria si sarebbe concentrata su tale tema. L’unico – tra quelli investiti dai referendum sulla giustizia – in grado forse di “scaldare i cuori” degli elettori (o almeno di alcuni). Per la verità i cuori degli elettori sarebbero stati scaldati di più dai referendum in materia di diritti civili (cannabis e omicidio del consenziente) che, se fossero stati dichiarati ammissibili, avrebbero probabilmente attirato alle urne la maggioranza degli aventi diritto al voto e in tal modo, per “trascinamento”, avrebbero consentito il raggiungimento del quorum anche sui quesiti concernenti la giustizia. Certamente l’intervento della Corte costituzionale è stato, sotto tale profilo, davvero “chirurgico”: ha eliminato dal campo di gioco i due referendum che avrebbero avuto un impatto più profondo nel dibattito pubblico. Ed inoltre, dei sei referendum in tema di giustizia (di per sé più tecnici e difficili da comprendere nelle loro effettive conseguenze giuridiche per un pubblico più vasto degli addetti ai lavori), ha dichiarato inammissibile l’unico che poteva essere facilmente spiegato a tutti, e che forse avrebbe portato più cittadini alle urne. Ritengo però una fortuna che la Corte lo abbia dichiarato inammissibile. La responsabilità civile diretta del magistrato, nella forma brutale che sarebbe risultata dall’abrogazione referendaria, avrebbe posto in crisi e seriamente minacciato non tanto e non solo l’indipendenza del giudice in quanto tale, ma la garanzia della sua imparzialità di giudizio. E dunque, in definitiva, il diritto di difesa di cui deve godere ciascun individuo in condizioni di uguaglianza con tutti gli altri di fronte alla giustizia. Secondo lei svolge un servizio migliore ai cittadini un giudice sereno o un giudice impaurito? Un giudice che può decidere la causa a lui sottoposta senza il timore di essere chiamato, in futuro, a rispondere economicamente, con il suo reddito e il suo patrimonio, della sua decisione dalla parte che sarà risultata soccombente, ovvero un giudice che deve sempre tenere conto del rischio che colui al quale avrà dato torto (specie se si tratta di un soggetto dotato di potere economico, una grande azienda, una multinazionale, un “potente”) potrà intentargli una causa civile per danni, magari per una cifra spropositata? Pensiamo a un processo per inquinamento ambientale a carico di una grande società petrolifera o a una class action nei confronti di un monopolista delle telecomunicazioni. Pensiamo, per fare alcuni esempi noti a tutti, ai giudici genovesi che devono giudicare le responsabilità della società Autostrade per il crollo del ponte Morandi o a quelli che si sono dovuti occupare della strage di Viareggio. O ancora, a quelli che hanno dovuto giudicare i fatti della Thyssen. In tutti questi casi il valore dei risarcimenti è di molte centinaia di milioni di euro. Sarebbero più sereni nel loro giudizio (anche soltanto sul piano delle pressioni cui potrebbero andare incontro durante il processo), se dovessero temere che un loro eventuale “errore” possa comportare conseguenze catastrofiche per il destino economico individuale loro e delle loro famiglie? Non è un caso che in nessun paese comparabile al nostro sotto il profilo delle strutture costituzionali fondamentali, della cultura giuridica, dei sistemi di garanzia dei diritti, è prevista in forma così brutale la responsabilità civile diretta del giudice per danni eventualmente derivanti da errori commessi nel corso del giudizio. Non è un caso che è sempre, ovunque, prevista una forma di responsabilità indiretta dello Stato, che “fa scudo” al magistrato a tutela della sua autonomia di giudizio e dunque a garanzia dell’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla giustizia. La stessa Corte costituzionale, in più occasioni, ha riconosciuto che il legislatore, in materia di responsabilità civile dei magistrati, deve sempre temperare le contrapposte esigenze che vedono coinvolti, da un lato, il soggetto ingiustamente danneggiato legittimato a ottenere ristoro per il pregiudizio subito e, dall’altro, l’indipendenza della magistratura. Una legge che preveda una disciplina ad hoc e più limitata della responsabilità civile del magistrato è, secondo la Corte, non solo costituzionalmente consentita, ma addirittura costituzionalmente dovuta, al fine di preservare «i disposti costituzionali appositamente dettati per la Magistratura (artt. 101 e 103 Cost.), a tutela della sua indipendenza e dell’autonomia delle sue funzioni» (così le sentenze n. 18 del 1989, n. 468 del 1990, n. 164 del 2017). Ricordo anche una raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 2010 sulle garanzie di indipendenza dei giudici, secondo cui «soltanto lo Stato, ove abbia dovuto concedere una riparazione, può richiedere l’accertamento di una responsabilità civile del giudice attraverso un’azione innanzi ad un tribunale». Si tratta di distinzioni e cautele doverose, a tutela di tutti i cittadini che si rivolgono alla giustizia.
In qualunque contesto, dividersi e separarsi significa indebolirsi e creare le condizioni per essere colpiti. La spaccatura che per anni si è consumata dentro la magistratura, e solo recentemente è divenuta più plastica agli occhi dei cittadini, ha alimentato una crisi di fiducia tale da dover ricorrere a un referendum. Non sarebbe stato meglio fermarsi prima? Costruire un processo volto a richiamare gli organi costituenti ai valori morali fondanti della democrazia e della garanzia per i cittadini, evitando il referendum? Non avrebbe dato un’immagine del potere meno distante dai cittadini?
Come dicevo prima, questi referendum sono stati fortemente voluti da una parte dello schieramento politico che non vedeva l’ora, anche ricorrendo a tale strumento, di “fare finalmente i conti” con la magistratura. I magistrati, che stanno subendo questa iniziativa, hanno sicuramente molte responsabilità nell’aver dato causa al clima di sfiducia che ne ha indubitabilmente indebolito il prestigio. Molti magistrati, peraltro, ne sono perfettamente coscienti e hanno subìto con disagio e preoccupazione i fatti di cronaca che i giornali hanno recentemente riportato. Alcune vicende patologiche che negli ultimi tempi hanno investito con inusitata virulenza il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura rischiano effettivamente di intaccare il prestigio dell’ordine giudiziario e di mettere fortemente in crisi il modello “esigente” che il Titolo Quarto della Costituzione preconizza. Talune indifendibili prassi e comportamenti di ordine clientelare e corporativo nell’ambito della gestione delle carriere dei magistrati e del funzionamento complessivo del sistema giustizia, emerse intorno al c.d. “caso Palamara”, hanno alimentato nel dibattito pubblico uno scandalo di proporzioni fino ad oggi sconosciute. Al punto da mettere in discussione non solo l’attuale organizzazione del sistema di governo autonomo della magistratura ma la stessa funzione istituzionale di quest’ultima. Ed è tale effetto che mi preoccupa. Perché la delegittimazione dell’ordine giudiziario mette in crisi lo stesso modello costituzionale che disegna l’equilibrio tra i poteri dello Stato. Ciò che ha cominciato ad essere apertamente contestato, non più soltanto dalle forze politiche che tradizionalmente, nell’ultimo quarto di secolo, avevano fatto della battaglia “contro la magistratura” un tratto caratterizzante della propria linea d’azione, ma da settori sempre più vasti dello schieramento politico (e alla fin fine, per forza di cose, da una parte dell’opinione pubblica), è una supposta autoreferenzialità del potere giudiziario, di cui molti contestano sempre più apertamente lo stesso ruolo costituzionale. Fino al punto di immaginare riforme legislative (quando non addirittura interventi di rango costituzionale) esplicitamente dirette a “limitare” l’esplicarsi del principio di autonomia e indipendenza. È questo l’humus nel quale è maturata l’iniziativa referendaria. A me, da osservatore esterno, sembra che tra i partiti, e all’interno dei partiti, sempre più numerosi siano coloro che non vedono l’ora di ridiscutere, sfruttando le attuali difficoltà in cui obiettivamente si dibatte la magistratura nel suo complesso, il “posto” del potere giudiziario nell’ordinamento costituzionale e il rapporto tra questo e gli altri poteri, alla ricerca di nuovi assetti e nuovi equilibri. “Fare i conti con la magistratura”, appunto, approfittando del suo attuale stato di indiscutibile debolezza e difficoltà sul piano istituzionale. L’uso del referendum è, in quest’ottica, del tutto strumentale, e se vogliamo “surrettizio”. Certo che “ci si sarebbe potuti fermare prima”. Il fatto è che gli errori si pagano, e oggi il prezzo da pagare – per la magistratura – è dover sopportare anche queste scomposte iniziative. Sono però contento di constatare che moltissimi magistrati, e molti settori della magistratura associata, sono perfettamente consci del problema e stanno riflettendo con serietà e responsabilità, al loro interno, dei rimedi da adottare per una “rifondazione etica” all’interno della loro categoria. Resto convinto che siano in primo luogo gli stessi magistrati (oltre, ovviamente, all’intera società civile, ciascuno facendo la sua parte in base al suo ruolo: istituzioni, intellettuali, giornalisti…) a dover contribuire con i propri comportamenti alla ricostruzione di un sentimento nazionale di fiducia nei confronti della giustizia. L’immagine deteriorata che, a partire dalle note vicende di cronaca, ha investito l’intero ordine giudiziario ha finito per creare una crescente diffidenza nei confronti del sistema. Nessuna riforma più o meno riuscita dell’ordinamento giudiziario (tanto meno una più generale o palingenetica “riforma della giustizia”) potrà invertire tale tendenza, se non sarà accompagnata o preceduta da una responsabilizzazione morale dei magistrati, che devono essere capaci di dimostrare a se stessi, prima di tutto, e a tutti i larghi settori della società italiana che ancora credono nel valore dell’indipendenza, dell’autonomia e del pluralismo culturale della magistratura, di non corrispondere al modello che l’odierna narrazione descrive.
Veniamo ora ai singoli quesiti. Credo sia utile infatti conoscere, nel caso il quorum venisse raggiunto, a quali cambiamenti andiamo incontro.
CONSIGLI GIUDIZIARI – Consentire il voto degli avvocati che siedono nei Consigli giudiziari anche sulle valutazioni di professionalità dei magistrati, è lo scopo dei referendari.
Nella sostanza cosa si vuole cambiare e quali perplessità suscita nell’ANM questo referendum?
La questione è molto tecnica. In estrema sintesi, il referendum è diretto a espandere il numero e il tipo di deliberazioni, tra quelle assunte dai consigli giudiziari e dal consiglio direttivo della Corte di Cassazione, cui possono partecipare i membri “laici” (professori universitari e avvocati) facenti parte di tali organi. I consigli giudiziari sono organi presenti in ogni distretto di Corte di Appello, ai quali competono una serie di funzioni “organizzative”, tra cui quella di fornire al CSM pareri inerenti la carriera e lo status dei magistrati che operano nel distretto. Da alcuni anni i consigli giudiziari sono composti, oltre che da magistrati (eletti dai colleghi) anche da componenti c.d. “laici”, ossia da professori universitari in materie giuridiche (designati dal Consiglio Universitario Nazionale su proposta delle università aventi sede nel distretto) e da avvocati (designati dai rispettivi ordini professionali). Orbene, i membri “laici” oggi non hanno diritto di voto con riferimento alle delibere «relative a carriera e status dei magistrati (in specie relative ai pareri sulle valutazioni di professionalità, su collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall’impiego, concessioni di titoli onorifici e riammissioni in magistratura dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto o già in servizio presso tali uffici al momento della cessazione dal servizio medesimo)». Il referendum mira appunto ad abrogare tale parte della normativa, onde consentire ai membri laici di partecipare anche a queste deliberazioni. Non mi risulta che l’ANM abbia espresso specifiche perplessità su questo specifico punto. La questione riguarda nuovamente il significato politico generale che il referendum assume, al di là del suo concreto esito normativo. La volontà, mi pare di capire, è quella di colpire (su un piano sostanzialmente simbolico) il “corporativismo”, la scelta “autoreferenziale”. Francamente non mi sembra che dall’eventuale partecipazione di un avvocato o di un professore ad una valutazione collegiale riguardante la professionalità di un magistrato (oltretutto all’interno di un collegio in cui la maggioranza dei componenti è comunque composta da magistrati, e il cui esito è comunque un mero “parere” non vincolante che sarà poi inviato al CSM), dipendano le sorti né dell’indipendenza della magistratura né della lotta al “corporativismo”.
ELEZIONE DEL CSM – Eliminazione delle liste di presentatori per l’elezione dei togati del CSM.
Qui credo che il cittadino abbia bisogno di una spiegazione procedurale: come funziona ora e cosa potrebbe cambiare?
Oggi, e salvo che la riforma della legge elettorale della componente togata del CSM attualmente in discussione alla Camera non entri in vigore prima di giugno (il che farebbe sì che il referendum non abbia più luogo), ogni magistrato che voglia candidarsi per un seggio al CSM deve essere appoggiato da un certo numero di colleghi che ne sostengano la candidatura. Ciò che è importante chiarire è che il sistema attualmente vigente non prevede “liste di candidati”, magari raggruppati sotto un simbolo (come avviene, alle elezioni politiche, per i simboli di partito). Ciascun magistrato ordinario può liberamente scegliere di candidarsi (a seconda della funzione da lui svolta) per una delle tre categorie tra le quali sono divisi i seggi da assegnare (due per i magistrati svolgenti funzioni di legittimità, ossia in servizio presso la Corte di Cassazione; quattro per i magistrati svolgenti funzioni requirenti di merito, ossia i pubblici ministeri; dieci per i magistrati svolgenti funzioni giudicanti di merito, ossia i giudici che operano negli uffici diversi dalla Corte di Cassazione).
Tuttavia, è previsto una sorta di “filtro”, diretto – nelle intenzioni del legislatore – ad evitare un eccesso di candidature. Chiunque intenda candidarsi deve trovare un certo numero di colleghi – non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta – disponibili a sottoscrivere e supportare la sua candidatura. Il referendum mira ad eliminare tale filtro, e dunque a consentire a ciascun magistrato eleggibile (cioè in pratica a ciascuno dei novemila magistrati in servizio) di candidarsi “liberamente” senza l’appoggio di colleghi. Ovviamente la ratio dell’iniziativa vorrebbe essere quella di “spezzare le reni alle correnti”: se non ho più bisogno di venticinque colleghi che appoggino la mia candidatura, non sarò più “schiavo” delle decisioni correntizie. In tal modo, ci si illude, verrebbero promosse più candidature “indipendenti”. La mia impressione invece è che verrebbero promosse molte candidature improbabili da parte di chiunque e senza alcun ragionevole filtro. Il supporto di 25 colleghi non è certo difficile da conseguire e già oggi non impedisce affatto che si manifestino candidature indipendenti. Al massimo il problema è che poi quei candidati indipendenti fanno fatica ad essere eletti. Ma come si può pensare, allora, che siano eletti candidati che non sono neppure in grado di farsi sostenere da venticinque colleghi? La verità è che, per ragionare seriamente di questi problemi, dovremmo affrontare la questione della formula elettorale, ossia del sistema elettorale in senso stretto. Si tratta ovviamente di una questione che non può essere aggredita per via referendaria, ma che ha bisogno di una discussione politica e di una riforma legislativa. Per favorire candidature autorevoli e indipendenti e difenderle dalle “logiche spartitorie” che purtroppo caratterizzano – come dimostrato dalle ultime vicende – l’attuale sistema delle correnti, possono immaginarsi vari strumenti che, tuttavia, non possono certo essere introdotti da un referendum. Per rispondere alla sua domanda, in conclusione, dall’eventuale esito positivo di questo referendum non cambierebbe assolutamente nulla. Forse si assisterebbe alla presentazione di qualche candidatura pittoresca in più, che però finirebbe per essere brutalmente stroncata dall’esito elettorale. Se l’obiettivo era quello di tagliare l’erba sotto i piedi alle correnti, mi pare un obiettivo prevedibilmente destinato all’insuccesso.
LEGGE SEVERINO/SEVERINO 2 – Sulla incandidabilità e decadenza dei parlamentari e di altri esponenti istituzionali.
Credo che questo punto meriti sia un’analisi tecnica sia qualche esempio pratico per far capire le insidie a cui si potrebbe andare incontro…
La c.d. “legge Severino” (in realtà un decreto legislativo, entrato in vigore nel 2012), stabilisce (tra l’altro) l’incandidabilità (e/o la decadenza dalla carica) per coloro che sono stati condannati (in via definitiva per i membri del parlamento, anche con sentenza di primo grado per i chi ricopre cariche elettive nelle amministrazioni regionali e locali) ad una pena superiore a due anni di reclusione per una serie di reati. Si badi bene: il decreto incorpora anche tutte le precedenti ipotesi di incandidabilità già previste dall’ordinamento. La volontà referendaria è proprio quella di rimuovere tutte le ipotesi di incandidabilità, a qualsiasi titolo e con qualsiasi effetto (provvisorie, definitive, temporalmente limitate, ecc.), anche quelle che erano già previste prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo in parola. L’obiettivo è di far venire meno l’istituto in sé dell’incandidabilità. Si prevede in sostanza l’abrogazione di tutte le norme che prevedono cause ostative all’assunzione e allo svolgimento di cariche elettive e di governo, derivanti da una condanna penale per taluni reati. Non si tratta soltanto di reati contro la pubblica amministrazione (corruzione, concussione, peculato, traffico di influenze illecite…). Si tratta, ad esempio, dei reati commessi dai pubblici amministratori collusi con la criminalità organizzata (l’associazione di tipo mafioso, il concorso esterno nella medesima, il voto di scambio politico-mafioso). Alcune di quelle ipotesi di incandidabilità erano state introdotte, ben prima della “Severino”, proprio per combattere i rischi di infiltrazione nelle amministrazioni locali, specie in alcuni comuni del meridione, da parte delle mafie. In caso di esito positivo del referendum, ogni singola ipotesi di incandidabilità verrebbe abrogata, con buona pace – a tacer d’altro – dell’art. 54 della Costituzione, secondo cui “i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore”.
Ora, sul significato complessivo della legge Severino, e financo sulla sua legittimità costituzionale in certi suoi aspetti (soprattutto laddove essa consente, a dispetto della presunzione di non colpevolezza, di rimuovere dalla carica gli amministratori locali colpiti da una sentenza di condanna non definitiva), si può certamente discutere. Una domanda, al di là di tutto, resta a mio giudizio ineludibile: cosa c’entra tutto ciò con l’organizzazione della magistratura? A meno di non voler sostenere, come mi pare facciano alcuni dei promotori, che proprio l’incandidabilità costituirebbe l’effetto dolosamente perseguito dai giudici che pronunciano sentenze di condanna a carico di politici e amministratori pubblici. E che dunque occorrerebbe sottrarre loro lo strumento che consentirebbe di condizionare il libero svolgimento delle competizioni politico-elettorali. Davvero i cittadini ritengono opportuno privarsi di uno strumento espressamente diretto a difenderli dalle infiltrazioni criminali nella pubblica amministrazione solo per scongiurare il rischio che taluni magistrati possano utilizzare speciosamente tale istituto?
SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DEI MAGISTRATI
Questo quesito credo meriti un chiarimento. Scritto cosi forse non é propriamente corretto.
Cominciamo con il chiarire che la “separazione” in senso tecnico delle carriere dei magistrati non può essere introdotta né con referendum né con legge. Occorrerebbe una modifica dell’art. 104 della Costituzione. Ciò che la legge può fare – e per inciso ha già fatto – è introdurre limitazioni alla possibilità per i magistrati – che comunque vanno reclutati tutti nell’ambito di un medesimo concorso – di passare nel corso della carriera dall’esercizio delle funzioni requirenti a quello delle funzioni giudicanti e viceversa. Attualmente la legge limita a due i passaggi dall’una all’altra funzione. Il referendum si ripropone di abrogare tutte le norme che consentono e disciplinano tali passaggi. È innegabile che la formulazione del quesito per un comune cittadino (ma in realtà anche per gli stessi addetti ai lavori) sia di difficilissima intelligibilità. Esso interviene su ben cinque leggi diverse e incide su questioni molto tecniche. In sintesi, si propone di abrogare la normativa sui passaggi tra una funzione e l’altra e bloccare i percorsi formativi che accompagnano i mutamenti di funzione. Pertanto, al magistrato che sia stato destinato, all’atto dell’assunzione in servizio, alla funzione di Pubblico Ministero o Giudice, sarebbe preclusa definitivamente la possibilità di chiedere il passaggio all’altra. L’effetto sarebbe quello di rendere irreversibile, attraverso l’abrogazione referendaria, la scelta operata dal magistrato all’inizio della carriera. Colui che, al momento in cui entra nei ruoli della magistratura e sceglie la funzione (oltre che la sede) di prima assegnazione, non potrebbe più, nel corso dell’intera carriera, mutare tale funzione. Inoltre, l’abrogazione referendaria produrrebbe l’ulteriore effetto di cristallizzare le funzioni attualmente esercitate dai magistrati in servizio alla data dell’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che dichiara l’avvenuta abrogazione delle norme sottoposte a referendum.
La questione della separazione delle carriere è certamente assai controversa e dibattuta. La mia personale opinione, maturata anche nel corso dell’esercizio della professione di avvocato, è che si tratti in realtà di un falso problema. La separazione delle carriere è concepita da molti come una sorta di vagheggiata “separazione delle vite”, diretta a precludere ogni potenziale contatto (sospetto di trasformarsi immediatamente in “collusione”) tra pubblici ministeri e giudici. Mi pare che non si tenga adeguatamente conto del fatto che da un lato le occasioni di incontro – e di potenziale collusione – sono infinitamente maggiori di quanto un’ipotetica separazione potrebbe garantire. Dall’altro, personalmente preferirei essere perseguito da un pubblico ministero che abbia esercitato, almeno per una parte della sua vita professionale, le funzioni di giudice. Una legge che volesse davvero, e sensatamente, perseguire l’intento garantistico che quel quesito promette, dovrebbe paradossalmente, proprio all’incontrario, costringere tutti i magistrati a svolgere, almeno per una parte della loro esistenza, sia funzioni giudicanti che funzioni requirenti. E magari costringerli ad esercitare, nel corso della carriera, sia le funzioni di giudice civile che quelle di giudice penale. Il buon magistrato è colui che non si sclerotizza per tutta la vita nella medesima funzione. Colui che vive esperienze diverse e sa trarre, da quelle diverse esperienze, le risposte per affrontare ed interpretare nella maniera più corretta possibile le infinite complessità che l’amministrazione della giustizia quotidianamente gli mette di fronte.
Chiudiamo con la stretta sulla custodia cautelare. Le chiedo di essere generoso con gli esempi perché tecnicamente è intuibile ma nella pratica ha tanti risvolti…
Il codice di procedura penale prevede che il giudice possa sottoporre a una misura cautelare (il carcere, ovvero gli arresti domiciliari, o ancora l’obbligo di dimora, o il divieto di avvicinamento a determinati luoghi, abitualmente frequentati dalla persona offesa, e così via…) chi sia gravemente indiziato di aver commesso un reato, soltanto qualora sussistano specifiche “esigenze cautelari”. Le singole esigenze cautelari sono a loro volta puntualmente individuate dalla legge. Una misura cautelare può essere disposta (oltre che nel caso, invero non frequente, in cui vi sia concreto e attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova, e nel caso, altrettanto poco frequente, che l’imputato si sia dato alla fuga o sussista concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga) soltanto qualora sussista «il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede». La medesima norma precisa infine che «le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell’imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede».
Il quesito referendario propone l’abrogazione delle parole «o della stessa specie di quello per cui si procede», nonché delle parole «le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell’imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede». L’effetto dell’abrogazione sarebbe di impedire al giudice di disporre una misura cautelare tutte le volte in cui il reato per il quale si procede non sia commesso con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, o non si tratti di un delitto diretto contro l’ordine costituzionale o di un delitto di criminalità organizzata. In buona sostanza, verrebbe impedito al giudice di disporre una misura cautelare (che, lo ripeto, non è solo quella della custodia in carcere, ma qualsiasi provvedimento in qualche modo limitativo della libertà personale) anche qualora sia altamente probabile che l’imputato, il giorno dopo, ricommetta il medesimo reato, a meno che il reato commesso non comporti l’uso di violenza. Facciamo qualche esempio. Lo spaccio di sostanze stupefacenti non è in genere commesso con violenza. Neppure il furto. Lo stalking è un reato che si consuma in genere mediante la persecuzione telefonica o la mera presenza fisica del persecutore sotto l’abitazione della vittima. E dunque quasi mai comporta l’uso della violenza. Il giudice non potrebbe più disporre alcuna misura cautelare per lo spacciatore seriale, per il ladro di appartamenti o di automobili che ogni notte viene sorpreso a rubare, per il fidanzato lasciato che continua a telefonare alla sua ex. Se questo fidanzato, per ipotesi, continuasse tutte le sere a presentarsi sotto la casa della vittima, senza usarle violenza, il giudice non potrebbe più disporre nei suoi confronti – come solitamente avviene in questi casi – la misura del divieto di avvicinamento alla dimora di lei (misura che in genere è assai utile a prevenire il fin troppo frequente passaggio dal mero “appostamento” alle vie di fatto…).
Proviamo poi a osservare le conseguenze di questa abrogazione referendaria in una prospettiva più generale di politica criminale. Mi pare che si voglia accreditare una concezione dell’uso della custodia cautelare che sottintende una ben determinata “percezione sociale” circa la gravità dei reati da perseguire. I reati commessi nell’ambito della c.d. “criminalità economica” (le bancarotte, i falsi in bilancio, le frodi fiscali, il riciclaggio), quelli contro la pubblica amministrazione (la corruzione, la concussione, il peculato, la turbativa d’asta), i reati connessi alla violazione delle norme a tutela della sicurezza sul lavoro – solo per fare qualche esempio – non sono mai, per loro natura, commessi “con violenza”. Lo sono invece, per definizione, le piccole rapine, i furti con strappo commessi in strada, le percosse, le risse. L’idea è che, da un lato, non debbano essere mai disposte misure cautelari nei casi dei reati dei “colletti bianchi”; mentre dall’altro lato si possano tranquillamente arrestare senza limitazioni particolari coloro che commettano reati, anche di lieve entità, tipici di chi vive nel disagio e nell’emarginazione sociale. E oltretutto con le conseguenze paradossali e vagamente strabiche cui ho fatto cenno sopra. In forza delle quali, chissà perché, non si potrà più arrestare lo spacciatore che tutte le sere vende hashish sotto casa mia, mentre lo si potrà fare con chi, anche solo una volta, mi ha strappato di mano la borsetta. L’evidente significato politico dell’iniziativa, al di là della sua intrinseca irrazionalità, mi pare essere quello di accreditare un nuovo bilanciamento di principi, un nuovo assetto dei poteri sociali, una nuova concezione dell’uguaglianza, largamente estranei allo spirito repubblicano che dovrebbe informare l’interpretazione dei principi costituzionali.
Prof. Grosso, grazie per averci illuminato sui contenuti e sui significati dei quesiti referendari. Un’ultima domanda. Crede che un rinnovo dell’Etica professionale dei magistrati debba sempre avere come prima fonte ispiratrice la Costituzione o i tempi attuali ci devono far riflettere su un insieme collettivo e generativo di norme che contribuiscano a dare valore morale e forza alla giustizia reclamata dai cittadini?
Io sono affezionato all’idea che, in una società pluralistica, i cittadini siano tenuti a vivere le loro preferenze morali, le loro opzioni politiche e dunque anche le loro concezioni della giustizia, entro la cornice di riferimento rappresentata dalla Costituzione. La Costituzione governa il pluralismo nel senso che consente a tutti di interpretare liberamente tali preferenze, stabilendo soltanto i limiti oltre i quali quella libertà metterebbe a repentaglio la stessa sopravvivenza pacifica della comunità nelle sue diverse articolazioni. La Costituzione è, e deve restare, il punto di riferimento, il baricentro su cui fondare e preservare la coesione sociale. Ciò vale anche per la magistratura. Spetta in primo luogo a quest’ultima, come ho già detto, recuperare presso i cittadini la credibilità perduta, avendo sempre nei principi costituzionali che ne governano poteri e limiti il proprio faro e la propria guida. E spetta alla politica evitare facili scorciatoie che, con la pretesa di interpretare non meglio individuate “esigenze di giustizia” che i cittadini reclamerebbero, minaccino la tenuta del fondamentale principio della separazione dei poteri, di cui l’autonomia, l’indipendenza e l’imparzialità della magistratura costituiscono un tassello imprescindibile.